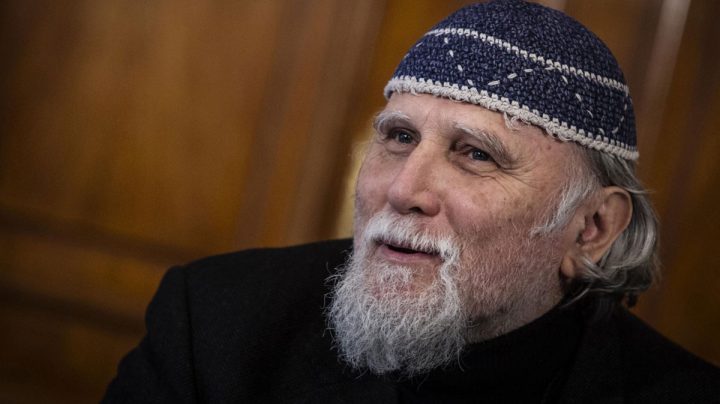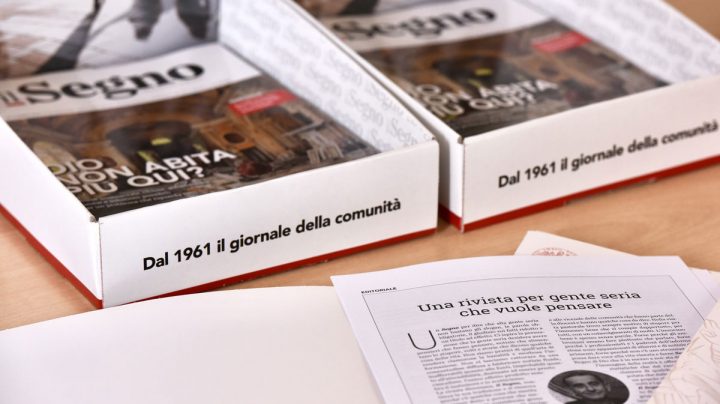La povertà è tradizionalmente associata alla mancanza di lavoro e, dunque, a condizioni di disoccupazione o inattività. Tuttavia, avere un’occupazione non garantisce necessariamente protezione contro il rischio di povertà ed esclusione sociale. Sempre più spesso, infatti, si verificano situazioni in cui individui formalmente occupati si trovano comunque in condizioni di vulnerabilità economica. È questo il caso dei working poor, ovvero i lavoratori poveri: persone che, pur svolgendo un’attività lavorativa, percepiscono un reddito talmente basso da non riuscire a mantenere uno standard di vita al di sopra della soglia di povertà.
Secondo la definizione più comunemente adottata, sono considerati lavoratori poveri coloro che, pur essendo occupati, percepiscono una retribuzione annua inferiore al 60% della mediana delle retribuzioni nazionali. Questa definizione lega quindi il concetto di povertà lavorativa alla dimensione salariale – ossia a bassi salari. In Italia, il fenomeno ha assunto proporzioni significative. Secondo dati Istat, tra il 2010 e il 2022 la quota di occupati a rischio povertà è passata dal 9,5 all’11,5%. Le cause sono molteplici e riguardano le diverse componenti che determinano le retribuzioni annue, nonché la loro interazione con il contesto socio-economico.
La prima componente è rappresentata dalla retribuzione oraria, che da anni mostra una crescita pressoché nulla. L’Italia è infatti l’unico Paese dell’Unione europea in cui, nel 2023, i salari reali risultano inferiori rispetto al 2013.
In un decennio, mentre a livello europeo il potere d’acquisto delle retribuzioni lorde è cresciuto mediamente del 3%, in Italia è diminuito del 4,5%. Questo dato riflette una dinamica salariale stagnante, aggravata dalla recente impennata dell’inflazione, che ha ulteriormente eroso i salari reali. Un secondo fattore determinante è l’intensità lavorativa, cioè il numero di ore effettivamente svolte. Per molti occupati – spesso contro la loro volontà – l’orario è limitato dalla scarsa disponibilità di posizioni a tempo pieno. Il fenomeno colpisce in particolare la forza lavoro femminile: secondo l’Ocse, oltre il 50% delle donne occupate part-time in Italia vorrebbe lavorare di più, ma non ne ha la possibilità.
La terza componente è l’instabilità contrattuale, che riguarda in modo particolare i giovani. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei contratti a tempo determinato e una diffusione crescente di forme contrattuali atipiche, meno protette sia economicamente, sia dal punto di vista previdenziale. Questa precarietà si traduce in carriere frammentate, minore accesso al welfare e incertezza sul futuro.
In generale, quindi, la combinazione di bassi salari, ulteriormente erosi dalla crescita dell’inflazione, ridotta intensità lavorativa, instabilità occupazionale e fragilità contrattuale contribuisce in maniera determinante all’espansione del fenomeno della povertà lavorativa. Tale condizione colpisce in modo marcato i giovani, le donne e i cittadini stranieri, che rappresentano la parte più consistente dei lavoratori poveri in Italia.
La povertà lavorativa è inoltre fortemente legata alla composizione familiare. Una definizione alternativa di lavoro povero, infatti, non si focalizza tanto sui bassi salari, quanto sui poveri che lavorano. Questa seconda accezione tiene in considerazione la
povertà all’interno del nucleo familiare, nonostante la presenza di membri della famiglia occupati. Inoltre, consente di determinare le caratteristiche delle famiglie povere, elemento fondamentale per poter definire efficaci politiche di contrasto.
Nel 2023, l’incidenza di povertà assoluta è pari all’8,2% tra le famiglie in cui la persona di riferimento risulta occupata. Il fenomeno interessa 1 milione e 100 mila famiglie in totale. I dati Istat rivelano che questa tendenza è in peggioramento, in particolare nei nuclei in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente: in questo caso, l’incidenza di povertà assoluta raggiunge il 9,1%. La perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie ha inciso notevolmente su queste dinamiche.
Nel complesso, tra il 2013 e il 2023, la spesa media equivalente in termini reali è crollata del 5,8%, denotando un impoverimento generalizzato; il calo è stato più forte per i ceti bassi e medio-bassi. Questo ha contribuito ad ampliare le distanze in termini reali tra le famiglie più e meno abbienti.
I nuclei residenti nelle regioni del Mezzogiorno risultano i più svantaggiati. Inoltre, la presenza di figli minori è un fattore che espone maggiormente al disagio economico. Resta elevato anche il divario nell’incidenza della povertà tra famiglie composte da soli stranieri (35,6%) e quelle composte da soli italiani (6,4%).
Concludendo, l’espansione del fenomeno della povertà lavorativa indica chiaramente come il lavoro non sia garanzia di sicurezza economica.
Le cause sono profonde: stagnazione salariale, orari di lavoro limitati, precarietà e scarsa tutela contrattuale. Il fenomeno ricade sulle famiglie, tra le quali aumenta l’incidenza della povertà anche quando la persona di riferimento risulta occupata. Giovani, donne, cittadini stranieri, nuclei numerosi e residenti nelle aree più svantaggiate del Paese sono i soggetti più vulnerabili. In questo contesto, è urgente un ripensamento delle politiche del lavoro e redistributive, orientato alla tutela delle retribuzioni, alla promozione di occupazione stabile e di qualità e al rafforzamento del sostegno alle famiglie.
Elena Villar è ricercatrice presso il Dipartimento di economia e finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano