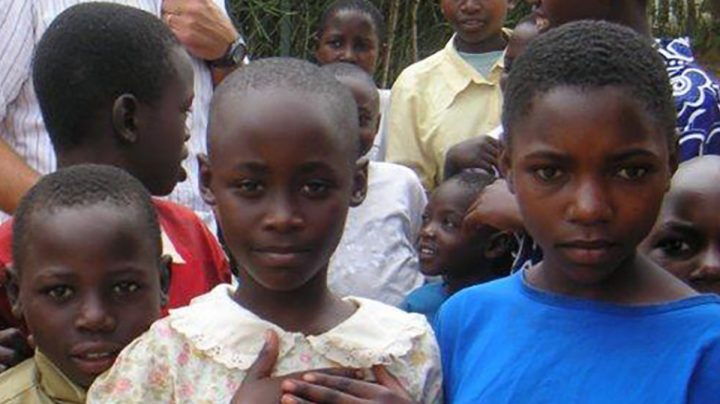Tra gli autori di narrativa non sono moltissimi quelli di fede cattolica che hanno inteso il loro mestiere come una vocazione e i loro libri come una forma di testimonianza evangelica. Ancor meno sono quelli che hanno retto al passaggio del tempo. Tra questi va senz’altro annoverata Flannery O’Connor, nata cento anni fa, il 25 marzo 1925, e morta neanche quarantenne a causa di una malattia ereditaria.
I suoi testi sono sempre sconcertanti: nella banale ordinarietà dell’esistenza, la grazia di Dio irrompe con violenza, spesso generando situazioni grottesche che spiazzano anche il lettore. I personaggi sono messi di fronte a una scelta cruciale in cui ne va della loro salvezza o perdizione.
Commentando le sue opere, scriveva: «In virtù dell’esperienza che mi viene dal tentativo di far “funzionare” i racconti, ho scoperto che quello che occorre è un’azione assolutamente inattesa, eppure assolutamente credibile, e ho riscontrato che, nel mio caso, essa indica sempre l’offerta della grazia. E spesso è un’azione nella quale il diavolo è stato strumento involontario della grazia». Questo riferimento al diavolo suona oggi decisamente démodé: non siamo abituati a prendere troppo sul serio una figura che abbiamo confinato in generi letterari affini all’horror o al fantasy, in ogni caso molto lontani dal crudo realismo della O’Connor.
Eppure, nella sua concezione, misurarsi con l’effettiva presenza del maligno è un passo necessario per accogliere il dono di Dio: «A garanzia del nostro senso del mistero, occorre un senso del male che veda il diavolo come uno spirito reale, spirito che va costretto a dichiararsi, e non semplicemente come male indefinito, bensì come una personalità specifica per ogni occasione». Il linguaggio scelto evoca la pratica dell’esorcismo. Capire che cosa intenda la scrittrice può aiutare, più in generale, a contestualizzare il senso di un ministero e di un rito che normalmente associamo alle superstizioni medioevali. La O’Connor insiste sul fatto che il male tende a dissimularsi per regnare indisturbato sul cuore dell’uomo. Farlo venire allo scoperto, scacciare ciò che occupa il posto di Dio è la condizione per aprirsi alla salvezza. Si tratta, in molti casi, di un’azione di forza, di una vera e propria lotta: «Il cielo è dei violenti», come recita il titolo di un suo romanzo.
Queste considerazioni, che intrecciano la libertà umana con la grazia divina, la determinazione a opporsi al male con la sconcertante scoperta di essere amati così come siamo, ci riportano ai temi del cammino quaresimale e del giubileo: nessuna fiction, è lo stesso mistero che tocca la vita di tutti con un realismo degno della grande scrittrice americana.